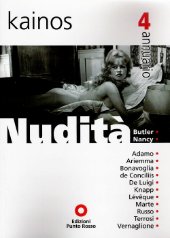Kainos Edizioni
Dal maggio 2022 su questa rivista non sono più accessibili molte immagini d'arte coperte dal copyright dei proprietari, ovvero generalmente musei e collezioni. Nella gran parte dei casi, l'immagine risulta vuota ma è leggibile la sua didascalia, per cui resta possibile la sua visualizzazione nei legittimi contesti.
Redazione e contatti
Cerca nel sito
Michael Hardt, Antonio Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico.
- Categoria principale: Percorsi di ricerca
- Categoria: Pratiche etico-politiche
- Pubblicato 09 Novembre 2010
- di Paolo B. Vernaglione
- Visite: 10253

Oltre il privato e il pubblico
ISBN 17038416
La bellezza del comune
Alla fine del IV capitolo del Libro I del Capitale Marx, per enunciare l’ essenza del capitalismo, lo sfruttamento, si serve di una immagine vivida che ritrae l’orizzonte della seconda rivoluzione industriale. Ci spinge ad “entrare nella sede nascosta della produzione” per farci osservare da vicino ciò che all’esterno chiassoso è celato, cioè il modo in cui si produce plusvalore, con il consumo della forza lavoro acquistata sul mercato.
Nell’ultimo libro di quella che si può considerare la trilogia dell’impero scritta da Michael Hardt e Antonio Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico (Commonwealt) gli autori ci fanno entrare nel laboratorio della post-modernità in crisi per osservare le dinamiche, oggi non più nascoste, dell’appropriazione del comune da parte del capitale.
Mentre per la seconda modernità Marx aveva previsto l’evoluzione dei rapporti di capitale in rapporti di dominio, cioè rapporti sempre più complessi, automatici e tecnicamente potenti, Negri e Hardt descrivono l’attuale panorama biopolitico come una dinamica in cui la forma neoliberista dello sfruttamento tenta di soggiogare continuamente le forze produttive.
Per Marx il capitale nella sua continua espansione deve superare ostacoli di ogni genere, dai rapporti di produzione esistenti alla rendita fondiaria, alle giurisdizioni feudali, alle aristocrazie. Oggi, come argomentano Negri e Hardt, è il capitale l’ostacolo principale all’esplicarsi della produzione biopolitica: nelle reti informatiche con brevetti e copyright e con la delimitazione di enclosures nella proprietà immateriale. Con la logica del “riconoscimento” identitario nelle politiche di genere; con la valorizzazione dei saperi, nella produzione di conoscenza; con la gestione delle energie alternative; con la riduzione a merce del lavoro e della produzione sociale.
La tesi principale di Negri e Hardt è che, a differenza della modernità, in cui l’organizzazione della forza-lavoro in partiti, sindacati e istituzioni politiche repubblicane, aveva trovato nel welfare statal-nazionale la mediazione del conflitto tra capitale e lavoro, oggi il mutamento di forma dell’intero ciclo della produzione non proviene tanto dall’appropriazione di forza lavoro e mezzi materiali, bensì dalla predazione del comune.
Il comune sono i beni naturali e le forme di energia che madre terra offre in abbondanza, ma soprattutto le facoltà relazionali, linguistiche e affettive che determinano la natura umana. Questa produzione biopolitica è la matrice della rottura epocale che si esprime in una molteplicità di forme di vita sottratte alle tradizionali modalità di sfruttamento e sottoposte ad una integrale presa mercificante.
La crisi non consiste tanto nella diminuzione di produttività, nel blocco dei salari, nella stagnazione o nell’aumento della disoccupazione, che sono indicatori inerenti ad una fase della modernità capitalista in cui la misura del valore era data dal rapporto tra pluslavoro e lavoro necessario. Consiste nella modalità di appropriazione del comune, che provoca blocchi, distorsioni, disparità feroci, ma anche resistenze e insubordinazione, per il fatto che alla misura del valore si è sostituìta la dismisura inerente a ciò che viene appropriato: sapere, linguaggi, codici, affetti.
E’ il divenire profitto della rendita e in genere il furto di “esternalità” a generare crisi. Il capitale non è più da tempo produttivo, non investe nei mezzi di produzione, ma tende a catturare profitto all’esterno, dalle risorse comuni, naturali e non. Questa dinamica sconvolge l’intero assetto delle economie, delle politiche, delle dislocazioni e stratificazioni sociali. I fenomeni di cui parliamo non risalgono a mesi ma ad anni, ormai in realtà decenni, almeno dagli inizi degli scorsi anni Ottanta, in cui l’inversione di politiche pubbliche in flussi privatizzanti ha dato corso alla finanziarizzazione e mercificazione della vita. All’interno di questo capitale affamato e predatorio quanto più è in crisi, si muove una potenza fatta di corpi singolari, che abitano sia i margini che le periferie di un potere diffuso, sfrangiato in territori metropolitani che hanno conosciuto un radicale mutamento: insieme a processi di “gentrificazione” le metropoli producono desideri, spettacolo, servizi, rendita immobiliare e povertà “ricca”, nonché tutte le forme di antagonismo che il capitale rende possibili e che allo stesso tempo gli sono irriducibili.
In questo orizzonte si gioca infatti una partita “per la vita”, di cui il testo restituisce un quadro di estrema nitidezza. Comune infatti è un libro in cui echeggia l’urgenza di una teoria e di una prassi politica che derivano dal disastro del neoliberismo, nella stratificazione della crisi che ha trascinato con sé non solo il fallimento dello sviluppo proprietario, ma anche l’illusione socialdemocratica del ripristino di uno stato sociale quale rimedio alle privatizzazioni.
Non a caso già prima della crisi dei mutui subprime, che ha creato il devastante scenario che abitiamo, i conflitti intorno al comune hanno costituito pratiche e strategie di conflitto per soggetti e reti di cooperazione, migranti, precari, studenti, collettivi e spazi territoriali, che agiscono oltre la rivendicazione di pubblicità in cui ancora è attardata la sinistra che residua.
La produzione biopolitica investe direttamente la cosiddetta dimensione “intima” degli esseri e le dinamiche di cattura che vi ineriscono non consistono in una semplice sostituzione di beni appropriati. Non si tratta, ed è questo il punto nevralgico che anche i due precedenti testi di Negri e Hardt provano ad indagare, di un passaggio meccanico dal plusvalore estorto nel processo di produzione a quello estratto nell’intero tempo-di-vita, bensì di un pluslavoro non misurabile perché si tratta delle facoltà umane intellettive, delle abilità acquisite, delle conoscenze e della cooperazione in cui si esprime l’intera vita. Come gli autori affermano, è questa eccedenza propria della produzione biopolitica a far saltare la legge del valore (e la stessa definizione di capitale variabile); e del pari, questa eccedenza rende complicata la descrizione e la critica di una inedita legge dello sfruttamento, che va tuttavia cercata nella stessa produzione, non fuori.
La sfera intima della vita, in cui affetti e relazioni amorose, ricchezza sociale e saperi diffusi si amalgamano e urlano autonomia e gratuità è infatti il rovescio della cancellazione dei confini tra un esterno e un interno globali – che travalica la singola condizione esistenziale.
Sono allora le potenze dell’amore e della povertà, intese in senso non religioso nè istituzionale, bensì come facoltà di “essere affetti”, oggi mobilitate sia per la cattura sia per la liberazione. La novità di questo episodio, rispetto ad Impero e Moltitudine consiste in questo: l’aver pensato amore e povertà come qualificazioni della produzione di soggettività, come categorie politiche in grado di sottrarsi e rispondere all’estensione dei biopoteri, graduando l’agire, dall’indignazione, alla disobbedienza, alla ribellione.
Amore e povertà nel testo sono infatti sia principi di selezione che di organizzazione. Sono proprietà comuni della moltitudine che deve discernere tra buoni e cattivi incontri, tra derive regressive, razziste e securitarie, o familistiche e statocentriche e condivisione e contaminazione con l’altro; l’altro non è il prossimo come oggetto di carità, ma il differente, il divenire altro (animale, molecola, muta, millepiedi) di nietzscheana e deleuziana memoria.
(Un rilievo al proposito: cosa accade se si intende questo divenire come un’invariante biologico-linguistica della natura umana? Si tenta una naturalizzazione della politica, oppure si sperimenta un canone di derivazione del comune dalla comune natura? Sarebbe interessante, come lo scrivente tenta da qualche tempo, un confronto teorico, all’interno della “tradizione” postfordista, tra l’affermazione di una contingenza storicizzata del concetto di natura e l’emergenza di un’istanza biologica, linguistica e storico naturale che racconti la natura del capitale…).
E’ dunque l’intera costellazione post-umana che amore e povertà sintetizzano, ad essere presa nel modo biopolitico di produzione. Quel modo, o meglio quel regime di verità che, con Foucault consta di due strati opposti e inestricabili: quello del controllo e del disciplinamento e quello della produzione di soggettività. Se è vero che il dominio si attua solo su esseri liberi, è la libertà che eccede qualsiasi misura del valore e costituisce, ancora nietzscheanamente, un nuovo valore, differente da tutti gli altri perché non trascendente bensì immanente al divenire, ai flussi, alle concrezioni del desiderio. La libertà è il divenire stesso, il divenire ciò che si è, in cui amore e povertà sono potenze di affermazione e di conversione.
(Per inciso, l’attraversamento della modernità in cui consiste l’attuale tramonto, ridisloca il pensiero di Benjamin proprio sulla linea di frattura con il moderno, in cui trova conferma il materialismo storico. Sarebbe interessante indagare insieme con gli autori le ragioni dell’impraticabilità di un Benjamin rivolto al passato, come il suo angelo…E’ forse questione di nostalgia?)
Raccogliendo ed elaborando una estesa mole di analisi e radiografando puntualmente lo stato del pensiero critico nel mondo, Negri e Hardt offrono uno strumento interpretativo della realtà globale all’altezza delle sfide che già impegnano costituende reti e soggettività resistenti e insubordinate, interne alla governance globale che in questo inizio del XXI secolo ha fatto fuori sovranismo nazionalista, rappresentanza e identità e l’intero armamentario teorico politico lavorista novecentesco.
Una ulteriore differenza di Comune sia rispetto a Impero e Moltutidine che alla temperie in cui si sono mossi i movimenti tra Seattle e l’invasione dell’ Iraq, consiste nel fatto che mentre ad una fase espansiva corrispondeva una complessiva ridislocazione del capitale nella forma dell’economia finanziaria, all’attuale débacle del neoliberismo e al fallimento del “colpo di stato” unilateralista statunitense, non corrisponde una ripresa d’attività di quella potenza biopolitica, che oggi si esprime come produzione tout court, nei flussi deterritorializzati di una precarietà strutturale, nella devastazione delle istituzioni del sapere e della conoscenza, nella torsione securitaria che stringe dure pratiche di disciplinamento; per non dire del ritorno di un fondamentalismo che ha appunto “la vita” come posta in gioco, specie sul corpo delle donne, dei “diversi”, dei ribelli e di chi tenta di costruire un’altermodernità.
Il testo affronta l’insieme delle questioni tematizzando alcune cruciali articolazioni filosofico-politiche che un’ ampia letteratura ha profilato in questi anni:
1) L’inservibilità delle teorie dello stato d’eccezione e del trascendentalismo repubblicano (teorie del patto, dell’agire comunicativo, della giustizia), sostituite da pratiche governamentali e “politiche dei corpi”, già al centro dell’opera di Foucault, risignificate da Deleuze e Guattari e oggi da Donna Haraway, Linda Zerilli, Wendy Brown, Judith Butler (ma a questa tramatura andrebbe forse premessa una distinzione tra filosofia e politica e forse andavano relativizzate le diverse filosofie, obiezioni e critiche che il pensiero italiano e non ha prodotto al concetto di moltitudine e di impero).
2) Il rilevamento di una cartografia della moltitudine quale soggetto de-soggettivato dell’agire, in processi costituenti che ne orientano e selezionano la prassi e non ne disattivano la potenza (ma anche in questa tesi l’orizzonte problematico costituìto dal concetto di “nuda vita” andrebbe, a parere di chi scrive, indagato filosoficamente, prima che politicamente…)
3) L’individuazione di una altermodernità, fonte di resistenze, disobbedienze e conflitti per la libertà che attraversa gli studi postcoloniali ed è testimoniata dalle radicali trasformazioni che in America Latina, in Cina, in India investono anzitutto lo stato e i processi produttivi, nonché le reti di cooperazione.
4) L’evoluzione del post-fordismo come dimensione di cui è intramata l’intera infrastruttura mondiale e che innerva le figure della produzione di sapere, di merci immateriali, le dinamiche della “femminilizzazione” del lavoro, della valorizzazione affettiva e della cura, in cui povertà e amore risiedono in luogo di identità, riconoscimento e delega.
5) Un concetto di rivoluzione che, a partire dall’emergenza della moltitudine, rompe con la tradizione comunista della presa del potere, dell’egemonia, dell’avanguardia consapevole e dell’organizzazione identitaria delle soggettività antagoniste ed è invece immersa nella produzione biopolitica che si oppone dall’interno al capitale.
Il confronto che Negri e Hardt intraprendono con la filosofia e la teoria critica è a vasto raggio e il libro offre attraverso le risposte critiche alle obiezioni di filosofi e teorici, una rassegna sintetica delle problematiche che il pensiero più vivo e radicale ha prodotto in questi anni.
In particolare, l’accentuazione sul concetto di comune non tanto come insieme dei beni “non consumptibiles” per ricordare una definizione adoperata da Hannah Arendt, bensì come facoltà e potenza della cooperazione e del linguaggio, apre il concetto ad un esame filosofico che precede qualsiasi descrizione politica, economica e sociologica.
Esiste infatti un pensiero del comune che si confronta con il pensiero della sovranità (viariamente declinata). Soprattuto esiste una prassi del comune che praticando l’esodo della società del lavoro, dalle insostenibili e irritanti alternative pubblico-privato, da un riformismo corruttivo e degradante (la famiglia, l’impresa, la nazione), dalle nostalgie della lotta di classe intraprese da un partito e da quelle per una premodernità anticapitalista triste, auspicata dalle teorie della decrescita, come dai riconoscimenti di genere, si manifesta come potenza del divenire, come forza destrutturante, come divenire altro della natura stessa.
E’ questo l’orizzonte di pensiero del comune, l’alterità in cui consiste la molteplicità delle differenze, la disarticolazione dei dispositivi di controllo e ordinamento, l’immediatezza di una contaminazione in cui ogni divenire soggetto si decompone nell’essere molteplice di una non identità.
Sulla base di una filosofia “minoritaria”, da Duns Scoto a Machiavelli, a Spinoza, Marx, Nietzsche, Foucault, Deleuze, il pensiero femminista e queer, la nozione di comune si declina nelle singolarità, nella differenza (anzitutto quella tra potere e potenza, fondamentale), nella logica che oppone lavoro e forza-lavoro in cui si compie ogni conflitto.
Quella che di solito viene definita organizzazione della moltitudine e su cui la sesta parte del testo si incentra non può dunque essere la comune rivoluzionaria agita da un partito o da un’avanguardia. L’eventuale “ricomposizione” del soggetto del comune è infatti anzitutto una scomposizione e una contaminazione tra molteplicità in divenire. In secondo luogo la creazione di istituzioni del comune avverrà per condivisione di pratiche, di saperi, di situazioni ed eventi, nel “fare rete” tra singolarità che non vorranno accedere ad alcuna verità del conflitto di classe; in terzo luogo questa aggregazione in divenire il cui strato primario è la riappropriazione, produce a sua volta una “diagonale” rivoluzionaria, cioè un taglio obliquo delle aggregazioni e delle appartenenze che le apre alla variazione. In una parola produce democrazia.
Il concetto e il nome del comune è democrazia, ma non il regime democratico parlamentare, né la rappresentanza, né le mediazioni nella sfera pubblica welfarista; bensì la democrazia del tumulto, la democrazia come conflitto, come restituzione di potenze senza alcuna sintesi dialettica, o confronto democratico, come nella retorica del ceto politico post-repubblicano.
Le istituzioni del comune sono la democrazia del comune, cioè la capacità e l’attualità di una istanza territorializzata, in cui consiste l’esodo perenne della de-territorializzazione, soprattutto nel corpo vivo della metropoli.
E’ evidente d’altra parte che questa sperimentazione territoriale non deve essere escludente, perché, ancora con Spinoza e Deleuze, qualsiasi incontro conta, basta che non generi una rapporto di decomposizione.
Nella composizione dunque consiste una moltitudine autorganizzata (sulla scorta molto convincente del paradigma autopoietico, ma come concepito dalla biologia di Maturana e Varela, e dal costituzionalismo multilevel di Teubner piuttosto che dalla teoria sistemica di Luhmann…). A queste condizioni, è possibile almeno pensare una forma in divenire dell’organizzazione, non come forma di un soggetto che si deve strutturare, bensì di un mondo organico che dev’essere. Infatti “tutti saranno sepolti da una risata”.
Laboratorio filosofico “sofiaroney.org” http://sofiaroney.org
Il Portale
Siti amici
Statistiche
- Visite agli articoli
- 2873904
Abbiamo 22 visitatori online