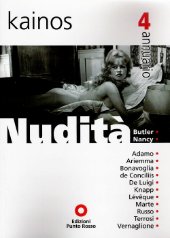Kainos Edizioni
Dal maggio 2022 su questa rivista non sono più accessibili molte immagini d'arte coperte dal copyright dei proprietari, ovvero generalmente musei e collezioni. Nella gran parte dei casi, l'immagine risulta vuota ma è leggibile la sua didascalia, per cui resta possibile la sua visualizzazione nei legittimi contesti.
Redazione e contatti
Cerca nel sito
In questo mondo libero, di Ken Loach
- Categoria principale: numero 13 - derive del lavoro
- Categoria: Percorsi (numero 13)
- Pubblicato 28 Dicembre 2013
- Visite: 6075
In questo mondo libero (2007), di Ken Loach
Il disprezzo che Loach nutre nei confronti del neoliberismo e delle politiche di deregulation delle questioni sociali, trova in questo film una delle sue migliori concretizzazioni. La ferocia con cui la protagonista Angie mette in piedi un sistema di sfruttamento dei lavoratori immigrati nella periferia di Londra, fino a restarne vittima e costringerla infine a rinunciare ai suoi sogni di affermazione sociale sulle disgrazie altrui, è ben equilibrato dalla totale assenza di strutture statali in grado di aiutare le masse di esclusi ad avviare un percorso di inclusione sociale. Il pubblico latita, il privato ricorda lo stato di natura hobbesiano, e forse l’unica speranza è il superamento della lotta tra poveri e il ritorno dello Stato alle sue funzioni.
It’s A Free World (2007), by Ken Loach
Loach’s contempt about neoliberalism and deregulation policy of social troubles, is well shown in this recent movie. Angie is an extremely fierce and harsh woman, who tries to get rich through the exploitation of poor unemployed people coming from Eastern Europe and looking for a job. But there’s too much violence in the air and she must leave her own dream of social success upon other people’s disgrace. State institutions are totally absent in this area, private behavior reminds Hobbes’s “state of nature”, and maybe the only way out from this hazardous situation is to abandon this struggle between poor and to bring the State back to his social function.

In questo mondo libero
(It’s a Free World)
di Ken Loach, UK 2007, 96 min.
Quando non ricade in schemi troppo manichei, come accaduto in Carla’s Song (1996) o in Bread and Roses (2000), Ken Loach è ancora in grado di sfornare lungometraggi di notevole interesse e che appaiono destinati a restare nella storia del cinema contemporaneo di argomento sociale. È questo il caso di It’s a Free World, coproduzione internazionale che ha avuto un considerevole successo anche al botteghino e che affronta con grande efficacia il tema del lavoro precario in Gran Bretagna nel periodo di transizione fra il decennio di Tony Blair e l’inizio dell’amministrazione Gordon Brown. Nel film si intrecciano in modi decisamente riusciti due direttrici principali: una che potremmo definire “costante” (lo sfruttamento dei lavoratori salariati a giornata, quelli che in inglese vengono tradizionalmente definiti Daily Salarymen), e una “contingente” (la condizione di assenza dello Stato nella ricerca di lavoro da parte soprattutto di immigrati, vuoto che viene colmato da privati rapaci e molto attivi). È ben noto il profondo astio che Loach ha provato e tuttora prova nei confronti della visione del mondo di Blair, da lui accusato di aver messo in piedi solo una gigantesca farsa politica che ha svuotato il Labour Party della sua identità storica, mentre come premier si è in realtà disinteressato in modo progressivo delle fasce sociali più deboli e ha perfino incrementato il divario fra ricchi e poveri in Gran Bretagna nella distribuzione del reddito. In occasione dei funerali di Margaret Thatcher, il regista non ha perso l’occasione per dire la sua con un’immagine molto efficace: «Se la Thatcher era la suonatrice di organetto, Blair era la scimmietta»1.
Ma veniamo al film in questione e riassumiamone la trama. Dopo essere stata licenziata per aver reagito ad una molestia sessuale da parte di un facoltoso cliente, Angie decide di aprire una propria agenzia – insieme alla coinquilina, ed entro certi limiti amica, Rose – per inserire nel mondo del lavoro i numerosi immigrati in cerca di un’occupazione, provenienti soprattutto dall’Europa orientale. In questo modo le due donne passano dall’essere sfruttate allo sfruttare loro stesse i lavoratori che smistano nelle diverse aziende (soprattutto cantieri edili) che richiedono manodopera in nero o comunque a basso costo. Angie diventa in pochissimo tempo una spietata capitalista senza il minimo scrupolo, perfino più negriera di chi comandava su di lei fino a pochi mesi prima. Il padre di Angie cerca di farla ragionare sulla terribile realtà che lei stessa alimenta, sottolineando come da questo sistema ne escano vincitori solo i padroni e i mafiosi, ai quali non può succedere nulla proprio perché sono gli squali che sguazzano nell'oceano delle sofferenze altrui, ma la donna non accetta di essere un pesce piccolo e spiega di volere una vita migliore, con guadagni facili e possibilmente esentasse. Per non fare i conti con la propria coscienza, come in genere avviene in queste circostanze, ripete ritualmente che, in ogni caso, questo tipo di lavoro lo farebbe qualcun altro se lei non ci fosse, e che lo sfruttamento è pur sempre una invariabile della storia umana, non certo una sua invenzione. I guai per le due donne cominciano quando, dopo aver sperperato gran parte dei soldi destinati agli stipendi in discoteche e alcolici e non essere state pagate da un costruttore per un lavoro svolto dai loro operai, rimangono senza sterline per retribuire i lavoratori. Vengono allora minacciate di pesanti ritorsioni se non troveranno i soldi, e a quel punto Angie in particolare dovrà fare i conti con la realtà che ha tentato di negare fino a quel momento: ha cercato di ritagliarsi uno spazio in un settore molto sporco, nel quale non si dà una seconda possibilità a nessuno. Tornerà quindi a lavorare in un’agenzia di collocamento per immigrati per pagare i propri debiti.
Angie diventa in pochissimo tempo una spietata capitalista senza il minimo scrupolo, perfino più negriera di chi comandava su di lei fino a pochi mesi prima. Il padre di Angie cerca di farla ragionare sulla terribile realtà che lei stessa alimenta, sottolineando come da questo sistema ne escano vincitori solo i padroni e i mafiosi, ai quali non può succedere nulla proprio perché sono gli squali che sguazzano nell'oceano delle sofferenze altrui, ma la donna non accetta di essere un pesce piccolo e spiega di volere una vita migliore, con guadagni facili e possibilmente esentasse. Per non fare i conti con la propria coscienza, come in genere avviene in queste circostanze, ripete ritualmente che, in ogni caso, questo tipo di lavoro lo farebbe qualcun altro se lei non ci fosse, e che lo sfruttamento è pur sempre una invariabile della storia umana, non certo una sua invenzione. I guai per le due donne cominciano quando, dopo aver sperperato gran parte dei soldi destinati agli stipendi in discoteche e alcolici e non essere state pagate da un costruttore per un lavoro svolto dai loro operai, rimangono senza sterline per retribuire i lavoratori. Vengono allora minacciate di pesanti ritorsioni se non troveranno i soldi, e a quel punto Angie in particolare dovrà fare i conti con la realtà che ha tentato di negare fino a quel momento: ha cercato di ritagliarsi uno spazio in un settore molto sporco, nel quale non si dà una seconda possibilità a nessuno. Tornerà quindi a lavorare in un’agenzia di collocamento per immigrati per pagare i propri debiti.
Sul modo in cui lo sfruttamento viene affrontato in questo film, il cineasta di Nuneaton si è espresso in modo molto chiaro: «Lo sfruttamento è cosa nota a tutti. Quindi non si tratta di una novità. La cosa che ci interessa di più è sfidare la convinzione secondo la quale la spregiudicatezza imprenditoriale è l’unico modo in cui la società può progredire; l’idea che tutto sia merce di scambio, che l’economia debba essere pura competizione, totalmente orientata al marketing e che questo è il modo in cui dovremmo vivere, ricorrendo allo sfruttamento e producendo mostri»2. Ma dai modi in cui la trama viene sviluppata, e in parte anche grazie al supporto di tecniche di ripresa volutamente fredde e di esterni realizzati in sobborghi piuttosto degradati di Londra, risulta piuttosto evidente che non siano disponibili dinamiche diverse da quelle dello sfruttamento e della sopraffazione, almeno allo stato attuale. L’erosione della dignità umana del lavoratore precario, sballottato fra soggetti voraci che si nutrono della sua impotenza e delle sue paure (a partire da quella dell’espulsione come clandestino), diventa così il territorio sul quale lo sfruttamento domina incontrastato. E se il film è così ben riuscito, lo è anche perché non esiste alcuna pars costruens: sia nelle riprese che nella stessa sceneggiatura (premiata a Venezia col premio Osella) non si intravede alcuna alternativa alla brutalità di questa sorta di stato di natura hobbesiano in cui dominano violenza, rapacità, sopraffazione.
Così come non esiste la presenza di strutture statali valide, alternative a quella degli sfruttatori privati occasionali. Lo Stato si intravede solo nel momento in cui Angie è chiamata a fornire informazioni sulla propria attività davanti ad una commissione che deve giudicare, per conto del tribunale dei minori, se la donna sia in grado di assicurare una condizione economica stabile al figlio. Il problema della dismissione dei servizi pubblici da parte dello Stato è ovviamente un argomento di scottante attualità, ma il pessimismo di Ken Loach non è condiviso da tutti. Hobsbawm, ad esempio, ha affermato più volte che non è affatto detto che le istituzioni possano ignorare ancora a lungo queste esigenze: «Non è scontato che il capitalismo possa funzionare senza istituzioni come il welfare. E il welfare è di regola gestito dallo Stato»3. Il fatto che in uno dei paesi più sviluppati dell’Occidente si possa arrivare a certi estremi di indifferenza da parte della politica nei confronti di interi gruppi sociali, non vuol dire che tale indifferenza sia destinata a durare all’infinito. La politica ha sempre la possibilità di tornare sui propri passi, ad esempio ripudiando l’inganno neoliberista di lungo periodo della deregulation e frenando i deliri che ne sono conseguiti, come auspicato tra gli altri da Joseph Stiglitz4. Se si verificano le circostanze opportune, può risultare perfino interesse dell’economia che lo Stato torni a fare la propria parte nelle questioni sociali e nel mercato del lavoro, anche nell’Inghilterra del dopo Blair e dell’attuale amministrazione Cameron.
Nel film di Ken Loach ci sono infine alcuni elementi simbolici di un certo rilievo. Dal punto di vista psicologico e sociologico, è di particolare interesse il fatto che Angie, espulsa senza una giustificazione plausibile da un settore parassitario dell’economia, decida di rientrarci di soppiatto mettendosi in società con l’amica, in modo da poter usare le sue uniche competenze per salire anche lei sulla ruota girevole di quanti hanno la possibilità di arricchirsi sfruttando la disperazione di lavoratori due volte colpevoli: perché non specializzati e perché provenienti in massima parte da paesi extra-Schengen. Va da sé che la donna non sia minimamente animata dal desiderio di aiutare nessuno, tranne forse il figlioletto di cui non è nemmeno molto brava a prendersi cura.  Ciò che la dà tutta questa energia è la voglia di passare rapidamente sul versante di quelli che riescono ad arricchirsi in tempi brevi ai danni degli altri, concependo tale attività come unica occasione possibile di riscatto sociale. Almeno, l’unica possibile per lei. Il che consente di inquadrare criticamente It’s a Free World come un film squisitamente baumaniano, apparentamento che presumibilmente non piacerebbe più di tanto a Loach ma che appare legittimo. In Liquid Lives (2005) Zygmunt Bauman scrive: «Per essere individui, nella società degli individui, bisogna tirar fuori i soldi, un sacco di soldi; la corsa all’individualizzazione non è aperta a tutti, e seleziona i concorrenti in base alle loro credenziali»5. Se così stanno le cose, aggiunge Bauman, «non sorprende che l’individualizzazione crei disagio e disagiati»6, tipi umani che il sociologo polacco tende a polarizzare nelle due categorie archetipiche dei “consumatori felici” e delle “persone squalificate ed escluse”. Ebbene, perfino dal modo in cui cambia l’abbigliamento di Angie nel corso del film, denotando una progressiva (sebbene molto kitsch) ostentazione di capi relativamente costosi, è piuttosto chiaro che la donna sa benissimo di provenire dalla seconda di queste due categorie – o almeno di essere stata ad un passo dallo sprofondarci dentro in modo traumatico – e che cerca di sfruttare quanti appartengono irreversibilmente al mondo degli esclusi per poter avere diritto di cittadinanza nel club dei consumatori felici. Ma ci riesce poco e solo finché il meccanismo così congegnato non le esplode fra le mani: esito inevitabile perché, in più di un senso, ha sbagliato lei ad osare introdursi in un ambiente nel quale il pesce piccolo non ha speranze.
Ciò che la dà tutta questa energia è la voglia di passare rapidamente sul versante di quelli che riescono ad arricchirsi in tempi brevi ai danni degli altri, concependo tale attività come unica occasione possibile di riscatto sociale. Almeno, l’unica possibile per lei. Il che consente di inquadrare criticamente It’s a Free World come un film squisitamente baumaniano, apparentamento che presumibilmente non piacerebbe più di tanto a Loach ma che appare legittimo. In Liquid Lives (2005) Zygmunt Bauman scrive: «Per essere individui, nella società degli individui, bisogna tirar fuori i soldi, un sacco di soldi; la corsa all’individualizzazione non è aperta a tutti, e seleziona i concorrenti in base alle loro credenziali»5. Se così stanno le cose, aggiunge Bauman, «non sorprende che l’individualizzazione crei disagio e disagiati»6, tipi umani che il sociologo polacco tende a polarizzare nelle due categorie archetipiche dei “consumatori felici” e delle “persone squalificate ed escluse”. Ebbene, perfino dal modo in cui cambia l’abbigliamento di Angie nel corso del film, denotando una progressiva (sebbene molto kitsch) ostentazione di capi relativamente costosi, è piuttosto chiaro che la donna sa benissimo di provenire dalla seconda di queste due categorie – o almeno di essere stata ad un passo dallo sprofondarci dentro in modo traumatico – e che cerca di sfruttare quanti appartengono irreversibilmente al mondo degli esclusi per poter avere diritto di cittadinanza nel club dei consumatori felici. Ma ci riesce poco e solo finché il meccanismo così congegnato non le esplode fra le mani: esito inevitabile perché, in più di un senso, ha sbagliato lei ad osare introdursi in un ambiente nel quale il pesce piccolo non ha speranze.
Forse Angie e Rose avrebbero avuto maggiori possibilità di riuscita se avessero scelto un settore diverso e meno pericoloso, un settore dal quale non dipende la sopravvivenza stessa degli individui e delle famiglie. André Gorz, fondatore della cosiddetta “ecologia politica”, in testi come Métamorphoses du travail (1988) sostiene che a partire dagli anni ’80 «stiamo uscendo dalla società del lavoro senza sostituirla con nessun’altra»7. Il che significa che ormai ci troviamo ad operare fra i residui di quel mondo, al quale non possiamo che cercare di continuare ad aggrapparci disperatamente perché l’identificazione (sociale, anzitutto) del soggetto attraverso il proprio lavoro non è stata rimpiazzata da altri procedimenti validi. Ma allo stesso tempo sentiamo che siamo agli sgoccioli, anche perché ormai chiamiamo “lavoro”, job, Arbeit, работа certe attività che tradizionalmente rappresentavano opportunità solo momentanee e provvisorie, dalle quali si cercava di uscire il più rapidamente possibile. Lo sguardo di Ken Loach ha fatto perciò bene a posarsi su queste zone così degradate, anche per mostrarci quanto sia socialmente pericoloso continuare a lasciarle in condizioni di abbandono, nella speranza che la politica ricominci ad occuparsene, possibilmente in modo serio.
1 L’originale dell’intervista in cui è contenuta questa dichiarazione è apparso sul “Guardian” del 08.04.2013. Uno stralcio in italiano è disponibile online: www.lettera43.it/cronaca/i-minatori-inglesi-in-festa-per-la-morte-di-thatcher_4367590660.htm.
3 E. Hobsbawm, Non ci resta che il capitale, in: “l’Espresso”, 10.02.2012, p. 92.
4 Cfr. J. E. Stiglitz, I ruggenti anni Novanta. Lo scandalo della finanza e il futuro dell’economia, a cura di D. Cavallini, Einaudi, Torino 2004.
5 Z. Bauman, Vita liquida, a cura di M. Cupellaro, Laterza, Bari-Roma 2008 , p. 15.
6 Ivi, p, 16.
7 Cit. da G. Allegri e R. Ciccarrelli, Contro la subordinazione. Diritti, reddito, libertà, in: “Alfabeta 2”, 19/2012, p. 24.
Il Portale
Siti amici
Statistiche
- Visite agli articoli
- 2875607
Abbiamo 21 visitatori online