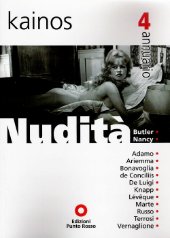Kainos Edizioni
Dal maggio 2022 su questa rivista non sono più accessibili molte immagini d'arte coperte dal copyright dei proprietari, ovvero generalmente musei e collezioni. Nella gran parte dei casi, l'immagine risulta vuota ma è leggibile la sua didascalia, per cui resta possibile la sua visualizzazione nei legittimi contesti.
Redazione e contatti
Cerca nel sito
12 anni schiavo, di Steve McQueen
- Categoria principale: Cinema
- Categoria: Recensioni (cinema)
- Pubblicato 10 Marzo 2014
- Visite: 23057

12 Anni schiavo
di Steve McQueen
con Chiwetel Ejiofor, Paul Giamatti,
USA 2013, 134 min.
Dopo il trionfo agli Academy Award, dove ha ricevuto l’Oscar come miglior film, migliore sceneggiatura non originale e miglior attrice non protagonista (Lupita Nyong’o), i premi vinti da 12 Years A Slave nei diversi contesti in cui è apparso finora superano quota cento1, facendone in modo inequivocabile uno degli eventi cinematografici della stagione 2013-2014. Costato 20 milioni di dollari sganciati principalmente dalla Plan B Entertainment e dalla River Road Entertainment, ne ha incassati finora circa 60 milioni, successo senz’altro superiore alle aspettative sia per i produttori che per lo stesso Steve McQueen, quarantacinquenne regista che in fondo è appena al suo terzo lungometraggio, dopo gli eccellenti Hunger (2008) e Shame (2011).
A differenza di quel che hanno sostenuto alcuni critici soprattutto britannici, in realtà la struttura narrativa non è molto diversa da quella di altri film sul tema della schiavitù. La presenza di un protagonista principale solo parzialmente omologabile agli altri malcapitati, questi ultimi rassegnati a dover trascorrere il resto della loro vita a raccogliere cotone, conferisce alla trama quella curvatura epica di cui c’era bisogno per candidare la pellicola agli Oscar e per darle un tono di esemplarità storica. L’attenzione nella scelta di esterni in grado di trasmettere allo spettatore una sensazione di vastità ma non di infinità, veicolata dalla sapienza del fidato direttore della fotografia Sean Bobbitt (collaboratore fisso del regista), non è certo qualcosa di nuovo nella cinematografia di un Paese che dispone di ambienti naturali per tutte le esigenze; l’espediente di limitare la portata laterale del grandangolo in alcune riprese dall’alto è invece una trovata piuttosto originale e che riesce a coniugare bene la percezione della fisicità di territori enormi ma non a disposizione di chi è stato privato della libertà.
Ciò che invece genera un’immediata distanza rispetto ad altre pellicole sulla schiavitù è il fatto che la vicenda si è realmente verificata e che fu raccontata a suo tempo dallo stesso protagonista, Solomon Northup, in un’autobiografia che non ebbe un particolare successo. L’uomo fu rapito nel 1841 da due trafficanti di schiavi, condotto con la forza in Georgia (che nel film diventa la Louisiana) insieme a molti altri neri sequestrati in modi analoghi e liberato solo nel 1853. È altrettanto e drammaticamente vero il fatto che l’uomo non ebbe mai modo di vedere puniti né i suoi sequestratori né i suoi aguzzini, poiché le leggi dell’epoca non lo permettevano. Il New York Times raccontò per la prima volta la sua storia sinteticamente in un articolo apparso il 20 gennaio 1853, ma la scarsa eco indusse Northup a scriverla con le proprie mani e in modo dettagliato, senza tuttavia ricavarne il desiderato riscontro. Il mondo dei media scoprì questa vicenda solo 130 anni dopo, quando la PBS ne fece un film per la Tv (Solomon Northup’s Odyssey) interpretato da Avery Brooks, oggi noto soprattutto come regista della nuova serie televisiva di Star Trek. L’adattamento dell’autobiografia di Northup per 12 Years a Slave è stato curato da John Ridley, noto romanziere, fumettista e sceneggiatore televisivo, il quale ha optato per due o tre tagli drastici rispetto alla narrazione di Northup e ha realizzato alcune modifiche necessarie a far respirare la sceneggiatura.
Fin dal momento in cui la vicenda prende la sua piega drammatica, ossia quando le diverse persone rapite si ritrovano insieme nella stiva di una grossa imbarcazione, legati o addirittura incatenati, non appena superata l’incredulità si presenta per loro l’interrogativo: cosa fare? È possibile reagire? Possono unire le loro forze per opporsi a ciò che sta accadendo? L’unico momento in cui si nota una dimensione collettiva di una possibile reazione è proprio durante la navigazione che porta i rapiti verso il Sud, quando alcuni di loro fanno un rapido censimento dei presenti a bordo della nave e, rendendosi conto di essere in maggioranza, cercano di indurre gli altri alla rivolta. Ma l’episodio, a differenza di quanto accadeva in Amistad di Spielberg, fallisce miseramente e si conclude in una giostra di frustate che elimina rapidamente ogni ipotetico slancio spartachista ulteriore.  Quando poi la nave approda e uno dei prigionieri viene liberato dal suo padrone (furioso perché non avrebbe dovuto finire tra i rapiti), ossia dal momento in cui i sequestrati rimettono piede sulla terraferma e iniziano il loro percorso forzoso verso la schiavitù, ogni componente collettiva cessa di esistere e prevale la pulsione di sopravvivenza, che è inesorabilmente individuale e individualista2. In un’intervista rilasciata a New York subito dopo il trionfo al Toronto Film Festival, il regista è stato molto chiaro su questo: «Per uno schiavo esisteva soltanto una questione: sopravvivere. Anche a costo di tenere fuori le emozioni, l’umanità (...) Non riesco neppure a immaginare il significato di nascere e crescere in un mondo in cui sei considerato nulla, la psicologia deviata in cui devi sopravvivere»3. Nel caso di Solomon Northup, che prima ancora di conoscere la sua destinazione come schiavo vive l’esperienza della perdita del nome e quindi (almeno nelle speranze dei suoi rapitori) della sua identità precedente, la sua intelligenza gli permette di affinare molti strumenti utili a ritagliarsi opportunità di sopravvivenza nel medio-lungo termine, ma che riguardano unicamente lui e che non può trasmettere agli altri.
Quando poi la nave approda e uno dei prigionieri viene liberato dal suo padrone (furioso perché non avrebbe dovuto finire tra i rapiti), ossia dal momento in cui i sequestrati rimettono piede sulla terraferma e iniziano il loro percorso forzoso verso la schiavitù, ogni componente collettiva cessa di esistere e prevale la pulsione di sopravvivenza, che è inesorabilmente individuale e individualista2. In un’intervista rilasciata a New York subito dopo il trionfo al Toronto Film Festival, il regista è stato molto chiaro su questo: «Per uno schiavo esisteva soltanto una questione: sopravvivere. Anche a costo di tenere fuori le emozioni, l’umanità (...) Non riesco neppure a immaginare il significato di nascere e crescere in un mondo in cui sei considerato nulla, la psicologia deviata in cui devi sopravvivere»3. Nel caso di Solomon Northup, che prima ancora di conoscere la sua destinazione come schiavo vive l’esperienza della perdita del nome e quindi (almeno nelle speranze dei suoi rapitori) della sua identità precedente, la sua intelligenza gli permette di affinare molti strumenti utili a ritagliarsi opportunità di sopravvivenza nel medio-lungo termine, ma che riguardano unicamente lui e che non può trasmettere agli altri.  Anche se all’inizio questa scoperta gli costa non poco e va contro la sua formazione culturale, col tempo la naturalità della pulsione prevale su ogni altro aspetto, e di fatto è proprio questa a garantirgli la vita e la liberazione finale.
Anche se all’inizio questa scoperta gli costa non poco e va contro la sua formazione culturale, col tempo la naturalità della pulsione prevale su ogni altro aspetto, e di fatto è proprio questa a garantirgli la vita e la liberazione finale.
In questo modo, si sostiene implicitamente che quell’individualismo tanto glorificato dalla allora nascente cultura americana, e che alla metà dell’Ottocento era ovviamente pensato come attributo caratteristico solo dei bianchi (si pensi a Walt Whitman e a R.W. Emerson), può riguardare invece anche gli afro-americani, il che in un certo senso preannuncia – anche se in una declinazione radicalmente diversa – anche il fumettistico “negro eccezionale” dello spaghetti western di Tarantino Django Unchained: in un caso l’eccezionalità permette di resistere all’orrore della condizione servile fino al ritorno in libertà, con buona pace dei bianchi possidenti; nell’altro di rovesciare gli equilibri di forza e le convenzioni sociali fino a ridicolizzare i bianchi razzisti usando contro di loro un lavoro inventato dai WASP stessi per garantire la propria sicurezza. Ma ovviamente l’epicità della parabola di Northup non può lasciare spazio all’humor irriverente della costruzione tarantiniana. Qui prevale il terrore, ed occupa tutto lo spazio umano lasciato a disposizione degli schiavi. Anche il procedimento mimetico che permette a Northup di sopravvivere recitando la parte dello schiavo-giocattolo analfabeta che i suoi padroni desiderano vedere è frutto della necessità concreta, non è certo un esercizio di recitazione: è sempre una reazione al terrore. Tuttavia, non si tratta affatto di un terrore passivo ma, al contrario, offensivo, utile a creare una barriera di parziale autonomia. Come ha ben scritto il corrispondente di Der Spiegel, Andreas Borcholte, dopo aver visto la pellicola al Toronto Film Festival, l’orrore visibile sul volto del protagonista Chiwetel Ejiofor (e su quello di pochi altri suoi compagni di sventura) per la situazione in cui si trova precipitato, privato con l’inganno e con la brutalità dei suoi diritti umani – che egli conosce perché, appunto, non è nato schiavo ma ha ricevuto un’istruzione adeguata – rappresenta la forza primaria del film, una sorta di antidoto violento alla violenza subìta4. Anche da questo punto di vista, direi che ci troviamo ad almeno una generazione di distanza dal socialmente ipercorretto serial Tv Radici (1977), che insisteva sul ruolo del leader-patriarca scelto dal destino per condurre la massa dei suoi fratelli verso la libertà. Qui, lo ripetiamo, il fenomeno è invece dolorosamente individuale, biograficamente delimitato, ed è proprio questo a rendere la trama convincente.
Pur non proponendosi apparentemente questo obiettivo, il film di McQueen è inoltre estremamente efficace nel mostrare anche la miseria dell’altra faccia dello schiavismo: quella riguardante i proprietari bianchi e il loro tenore di vita. In particolare durante la lunga permanenza nei possedimenti di Edwin Epps (Michael Fassbender, onnipresente nei film di McQueen e dotato di capacità interpretative di gran lunga superiori a quelle di tutto il resto del cast), il terzo è più brutale proprietario di Platt/Northup, lo spettatore non può non restare colpito da un particolare che non è affatto un dettaglio: questi ricchi che hanno tutto e tutto possono, in buona sostanza, dei soldi accumulati con le loro piantagioni non ne fanno nulla! Non li usano per ampliare le loro proprietà né per migliorare le loro lussuose abitazioni, non li investono per avviare altre attività né per mandare i figli a studiare in università prestigiose. Il loro status sociale viene associato unicamente al potere di punire gli schiavi non abbastanza produttivi e l’apoteosi della loro condizione di privilegiati si concretizza nell’ammirazione onanistica delle piantagioni che si estendono a perdita d’occhio. Gli unici momenti nei quali li si vede fare qualcosa di diverso dal solito sono le rare feste nelle quali mostrano di non andare nemmeno d’accordo tra di loro e dove difficilmente sono in grado di fare qualcosa in più del confrontare i rispettivi abiti. Insomma, una classe sociale incredibilmente parassitaria ma che, a differenza della coeva aristocrazia europea, non sa godersi nemmeno la batailliana dépense della propria ricchezza. Perfino le frustate che riservano ai neri ribelli non mostrano il tipico godimento del sadico in azione e sembrano concepite più sotto la categoria del dovere che sotto quella del piacere. E in effetti è giusto che sia così: sia gli schiavi che i loro padroni sono infatti ostaggio del medesimo sistema di produzione – che alla metà del XIX secolo ha iniziato il suo declino – e da esso dipendono entrambi, anche se in direzioni opposte e complementari.
Non li usano per ampliare le loro proprietà né per migliorare le loro lussuose abitazioni, non li investono per avviare altre attività né per mandare i figli a studiare in università prestigiose. Il loro status sociale viene associato unicamente al potere di punire gli schiavi non abbastanza produttivi e l’apoteosi della loro condizione di privilegiati si concretizza nell’ammirazione onanistica delle piantagioni che si estendono a perdita d’occhio. Gli unici momenti nei quali li si vede fare qualcosa di diverso dal solito sono le rare feste nelle quali mostrano di non andare nemmeno d’accordo tra di loro e dove difficilmente sono in grado di fare qualcosa in più del confrontare i rispettivi abiti. Insomma, una classe sociale incredibilmente parassitaria ma che, a differenza della coeva aristocrazia europea, non sa godersi nemmeno la batailliana dépense della propria ricchezza. Perfino le frustate che riservano ai neri ribelli non mostrano il tipico godimento del sadico in azione e sembrano concepite più sotto la categoria del dovere che sotto quella del piacere. E in effetti è giusto che sia così: sia gli schiavi che i loro padroni sono infatti ostaggio del medesimo sistema di produzione – che alla metà del XIX secolo ha iniziato il suo declino – e da esso dipendono entrambi, anche se in direzioni opposte e complementari.
La realtà storica documentata è però diversa da quella mostrata nel film: esistevano notevoli differenze sia in termini di stili di vita che di impegno lavorativo fra i possidenti delle aree attraversate dal Mississippi, quelli delle pianure costiere sul golfo del Messico che beneficiavano della presenza di porti commerciali molto attivi, i proprietari delle sterminate piantagioni al di là dei monti Appalachi e così via5. Insomma, la realtà storica è come sempre più complessa e occupa posizioni intermedie tra il lusso un po’ kitsch dei possidenti stile Via col vento e la miseria umana e morale del film di McQueen. Ciò nonostante, è notevole il fatto che in 12 anni schiavo si percepisce una situazione complessiva di stagnazione, di sterile ripetizione di gesti e comportamenti simili o identici in tutte le aree rurali attraversate da Platt/Northup durante il suo lungo calvario. La classe sociale destinata ad uscire vincitrice dai mutamenti dell’epoca non può essere visibile in quei campi perché è la borghesia produttiva del Nord-Est, ossia di quella parte degli USA da cui Northup proviene e a cui tornerà alla fine della vicenda, l’area economicamente e culturalmente più attiva, quella che prima del rapimento gli aveva permesso di conquistare una posizione relativamente agiata e sarà pronta a riaccoglierlo quando l’incubo sarà terminato, quella che alla fine abolirà la schiavitù. Dunque, McQueen ha dimostrato in questo film di saper raccontare sia l’orrore dello schiavismo, mostrandolo nella sua cruda disumanità, che la sua miseria tramite procedimenti ellittici riusciti. Nonostante alcune sequenze facciano pensare a scelte finalizzate a colpire certi tipi di pubblico e di giurie, non lo si può definire un Oscar immeritato.

Note al testo
1 Ricordiamone alcuni tra i principali: miglior film ai Bafta, ai Satellite Award, ai Boston Film Critics Association Awards, ai Critics' Choice Movie Award e al Festival del cinema di Stoccolma; miglior film drammatico ai Golden Globe; miglior regia (McQueen) agli African-American Film Critics Association Awards, ai New York Film Critics Circle Awards, ai Chicago Film Critics Association Awards e in un'altra decina di consessi cinematografici americani.
2 Sulle effettive condizioni di vita degli schiavi fino al periodo dell’abolizione, cfr. P. Kolchin, American Slavery, Penguin, London 1995.
3 Intervista tradotta anche in italiano: http://www.film.it/film/interviste/dettaglio/art/steve-mcqueen-12-anni-schiavo-tra-la-bibbia-e-pinocchio-39483/.
5 Su questo argomento, cfr. W.E. Clement, Plantation Life: On the Mississippi, Pelican Publishing Company, Gretna 2000; B.D. Schoen, The Fragile Fabric of Union: Cotton, Federal Politics, and the Global Origins of the Civil War, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011.
Il Portale
Siti amici
Statistiche
- Visite agli articoli
- 2874408
Abbiamo 24 visitatori online