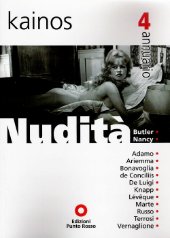Kainos Edizioni
Dal maggio 2022 su questa rivista non sono più accessibili molte immagini d'arte coperte dal copyright dei proprietari, ovvero generalmente musei e collezioni. Nella gran parte dei casi, l'immagine risulta vuota ma è leggibile la sua didascalia, per cui resta possibile la sua visualizzazione nei legittimi contesti.
Redazione e contatti
Cerca nel sito
La vie d'Adèle, di Abdellatif Kechiche
- Categoria principale: Cinema
- Categoria: Recensioni (cinema)
- Pubblicato 03 Novembre 2013
- Visite: 21710

«LA VIE D’ADÈLE»
regia di Abdellatif Kechiche
Premiato con la Palma d’oro a Cannes 2013, La vie d’Adèle. Chapitres 1-2 (giunto nelle sale italiane solo alla fine di ottobre) è probabilmente il film più ambizioso tra quelli finora realizzati dal cinquantenne cineasta franco-tunisino tanto apprezzato dalla critica, soprattutto da quella tenacemente aggrappata agli scogli del politically correct. Per la medesima ragione, è anche il film che maggiormente mostra i limiti strutturali di questo regista. La giuria presieduta da Steven Spielberg ha voluto citare esplicitamente nelle motivazioni le due interpreti del lungometraggio, precisando che «le Jury a pris la mesure de l’excellence de trois artistes: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux et Abdellatif Kechiche». Direi che Spielberg ha fatto bene a collocare solo in terza posizione il regista, dal momento che almeno i 3/4 del valore estetico del film sono merito dei notevoli sforzi fatti dalle due attrici, una delle quali, la ventenne Adèle Exarchopoulos (Adèle), era al debutto in un ruolo da protagonista, mentre la Seydoux (Emma) – nipote e pronipote dei presidenti di autentici colossi della cinematografia transalpina (Pathè Film e Gaumont), che ha già lavorato con registi del calibro di Ridley Scott, Amos Gitai, Louis Garrel e Tarantino – appare visibilmente più matura da ogni punto di vista. Non è eccessivo affermare che in non pochi momenti di questo film, sia sequenze cruciali che di transizione, la finzione proceda discretamente bene nonostante Kechiche e non certo grazie a lui, che pecca soprattutto in quanto a tecniche di ripresa, scelte di diffusione della luce, all’idea a dir poco infantile di non guidare lo spettatore nella successione cronologica degli eventi1 e per altri motivi ancora.
Che il film non sia e non voglia essere un’apoteosi del lesbismo, è comune denominatore a tutte le recensioni serie che sono state scritte, in Italia come all’estero. Léa Seydoux, intervistata al termine del festival di Cannes da un giornalista di TV5 Monde, ha giustamente dichiarato che in realtà questo «est un film sur les sentiments, sur la rupture, sur la solitude»2. Presumibilmente, il desiderio di Kechiche era quello di mostrare come le dinamiche di coppia, in particolare quelle che si verificano nel classico binomio dominante/dominato, siano sostanzialmente le stesse in ogni declinazione dell’eros. A ciò va aggiunto il particolare per nulla irrilevante che lo scorrere del tempo impone ai rapporti di coppia: un po’ per volta, tutto ciò che più in profondità siamo, ciò di cui siamo irreversibilmente fatti, emerge sempre, e pone implacabilmente fine al periodo in cui l’unione era un mero idillio.  In questo caso, il nucleo discriminante è la diversa estrazione sociale delle due ragazze, dalla quale dipende il diverso spessore nella formazione delle rispettive personalità, e quindi il fatto stesso che una della due è più debole e ha maggiormente bisogno dell’altra, mentre l’altra, Emma, sembra sapere perfettamente ciò che vuole e perciò rappresenta la personalità dominante della coppia.
In questo caso, il nucleo discriminante è la diversa estrazione sociale delle due ragazze, dalla quale dipende il diverso spessore nella formazione delle rispettive personalità, e quindi il fatto stesso che una della due è più debole e ha maggiormente bisogno dell’altra, mentre l’altra, Emma, sembra sapere perfettamente ciò che vuole e perciò rappresenta la personalità dominante della coppia.
La prima parte del film può così basarsi sulla graphic novel di Julie Maroh Il blu è un colore caldo (in Italia edita da Rizzoli Lizard), e questa parte risulta piuttosto convincente, nonostante una certa gratuità in alcuni richiami a La vie de Marianne di Marivaux, romanzo che Adèle legge al liceo per un corso di letteratura e nel quale ritrova certi spunti autobiografici, dato che la protagonista del celebre romanzo di Marivaux ha davvero dei tratti in comune con Adèle, essendo una sorta di collezione vivente di fragilità, incertezze, desiderio di protagonismo senza essere notata, ipertrofico bisogno di affetto. Marianne ama le sue debolezze, e vorrebbe che gli altri la amassero per le stesse ragioni, che lei percepisce come un merito, pur definendole come malheur dal punto di vista sociale: «Anzitutto la mia disgrazia, che era unica; con tale disgrazia avevo della virtù, e andavano così bene insieme; e poi ero giovane, e poi ero bella; che volete di più?»3 La conoscenza di Emma e la scoperta di una nuova e più appagante forma di vita attraverso lei, crescendo con lei, quasi nutrendosi di lei (come testimonia il rituale delle dita di Emma che vengono a trovarsi così spesso tra le labbra di Adèle, che le bacia, le succhia, le beve), rappresenta la fase crescente della sua parabola. Ma già in questa parte, ossia il capitolo 1 della vicenda, il regista opera alcune scelte tecniche a dir poco discutibili, in certi momenti semplicemente disastrose. Un conto è avvicinare la macchina da presa ai volti degli attori per enfatizzare pregi e difetti espressivi, lineamenti in nervoso e incessante movimento etc.; un altro conto è non capire quando ci si deve fermare, ossia rifiutare l’esistenza di una “giusta distanza” dall’oggetto, quanto meno in certe sequenze. Se vuoi realizzare un’opera che aspira ad avere un valore paradigmatico riguardo le modalità di Erlebnis dell’esperienza erotica giovanile femminile, e non stai semplicemente ripetendo gli schemi quasi dilettanteschi di Cous Cous (2007), che senso ha posizionare la mdp a pochi centimetri da labbra dai cui angoli colano rivoli di sugo alla bolognese mentre i personaggi stanno cenando? Ingigantire in modo pantagruelico quelle bocche come se le immagini fossero caricature del Pranzo di Babette o de La grande bouffe di Ferreri? E non è solo Adèle, ad essere coinvolta in scelte infelici come questa; lo sono anche i genitori, gli amici e le amiche della ragazza, e un po’ per volta anche Emma e le persone che gravitano intorno ad Emma. Eppure non mancano i posizionamenti ben riusciti della mdp, in particolare (e non è certo un caso) quando si allontana dal corpo nudo e dormiente di Adèle e lo riprende dalla giusta altezza e con la giusta inclinazione, oppure quando (in quello che dovrebbe essere il secondo capitolo) la ragazza ormai stremata dallo sviluppo degli avvenimenti giace sulla panchina del parco in cui la storia con Emma era iniziata e le foglie rossastre degli alberi autunnali cadono su di lei e intorno a lei, trascinate dal vento, quasi suggerendole di passare oltre, di superare la sua dipendenza, unica possibilità per lei di rafforzarsi come soggetto e avvicinarsi ad un minimo di autonomia.  E allora, dal momento che il film è stato totalmente girato in digitale con camere Canon C300, note per la loro leggerezza (appena 2,7 chili di peso) e per la loro versatilità (infatti vengono qui usate sia per riprese a mano che con supporto fisso), la responsabilità di ogni scelta nel loro posizionamento va fatta ricadere totalmente e unicamente sul regista.
E allora, dal momento che il film è stato totalmente girato in digitale con camere Canon C300, note per la loro leggerezza (appena 2,7 chili di peso) e per la loro versatilità (infatti vengono qui usate sia per riprese a mano che con supporto fisso), la responsabilità di ogni scelta nel loro posizionamento va fatta ricadere totalmente e unicamente sul regista.
Per non parlare di come la fotografia, diretta da Sofian El Fani, che già aveva collaborato con Kechiche in Venus Noire (2010), oscilli costantemente e inutilmente tra il teen movie americaneggiante (esterni giorno con luce alta laterale, perché nei film come nei telefilm americani di ambientazione liceale i ragazzi e le ragazze hanno quasi sempre gli occhi azzurri, che così brillano maggiormente) e combinazioni iperdrammatiche e vagamente teatrali, con quegli interni durante i lunghi amplessi fra le due ragazze dove non mancano candele posizionate in punti ritenuti strategici ma che non contribuiscono in alcun modo alla formazione della luce. Ovvio che poi non si registri una sola dissolvenza degna di questo nome, in un film dove di dissolvenze ce ne sarebbero volute, e anche molte. Insomma, come si può pensare seriamente di dare un tono magistrale ad una pellicola con tali ambizioni, mostrando di non saper tenere separati certi registri, certe soluzioni di ripresa, certe strategie di diffusione della luce a beneficio delle immagini che non possono essere mescolate?
Sostanzialmente, La vie d’Adèle è un film di cui l’Europa del XXI secolo aveva bisogno e che pertanto ha premiato, anche se non aiuterà molto a combattere l’omofobia dilagante nel vecchio continente. Ma è anche un lavoro che mostra i numerosi limiti della generazione di cineasti di cui Kechiche fa parte. Bergman aveva 48 anni quando girò Persona, che non affronta argomenti troppo diversi; Jacques Rivette ne aveva solo 41 quando fece L’amour fou (che dura 70 minuti più di La vie d’Adèle ma si digerisce molto meglio); Lars von Trier ne aveva 40 quando ha realizzato Breaking the Waves, che pure mostra con grande efficacia drammatica una dinamica dominante/dominato in un rapporto di coppia fortemente disfunzionale. Kechiche a 50 anni non è in grado di fare di meglio, a quanto pare, o forse non è il caso di aspettarsi più di tanto.

Note al testo
1 Se un autore sceglie di sottotitolare la propria opera “Capitoli 1 e 2”, mostrando con ciò l’intenzione di conferirle un tono narrativo forte, quasi solenne, a che pro far saltare gli elementi utili a separare le fasi che devono comporla? Se il desiderio era quello di introdurre un procedimento ellittico, è un desiderio che, dal punto di vista cinematografico, si realizza in ben altri modi.
2 L’intervista alle due interpreti è qui: http://www.youtube.com/watch?v=jdYGZXXWhQk.
3 P.C.Ch. de Marivaux, La vita di Marianna, a cura di R. Arienta, vol. I, Milano, Rizzoli 1951, p. 103.
Il Portale
Siti amici
Statistiche
- Visite agli articoli
- 2874553
Abbiamo 20 visitatori online